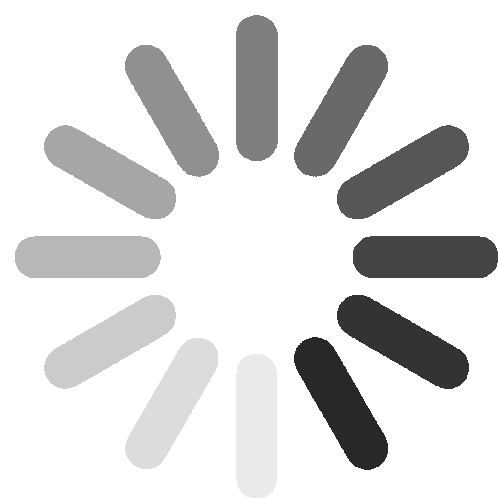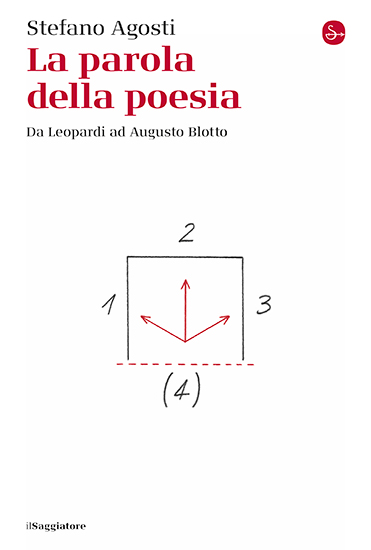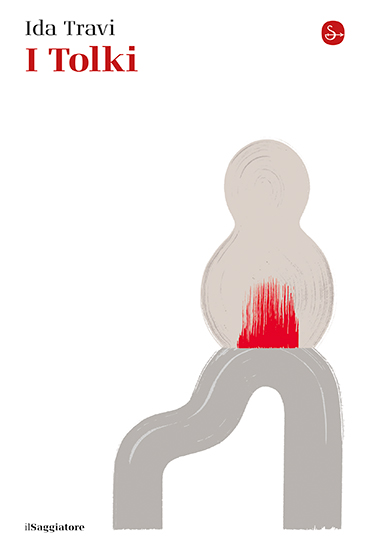Salutz
Salutz è poema della frattura e dell’ascesi, canto lirico di un amore che è insieme salvezza e tormento, innalzamento ed eros. Due sono i nomi con cui Giovanni Giudici si rivolge alla donna nei mille versi che compongono quest’opera centrale del secondo Novecento italiano: Minne e Midons, senhals provenzali e germanici dietro cui si cela la modernità di una poesia che è ricerca di sensi inattingibili, dissoluzione e ricomponimento, conflitto con gli spettri dell’io e lotta contro la resistenza del linguaggio. «Fate di me ora un angelo ora un rospo / Voi cielo e tomba voi di piombo e d’oro» scrive Giudici, e nella pluralità cortese del voi, come nella giustapposizione dei significati, traspare la binarietà della donna «bianca maga» e «maga nera», figura a cui sottomettersi eppure mai del tutto idealizzata, «primissima spina / E rosa di risveglio mattutina», luce e oscurità, «pube e nube». Ma a produrre lo scarto determinante, in Salutz, è l’aver fatto confluire la «vita in versi» – il magma dell’autobiografia e la carne viva dell’esperienza – entro il rigore di una struttura geometrica nel cui corpo è inoculata una «linguazebra» arcaizzante, squisitamente letteraria, pronta tuttavia a vertiginose fughe verso il basso, il sensuale e il quotidiano. Il solco è quello del plurilinguismo dantesco, e di un trobar clus che è specchio della moderna impenetrabilità del linguaggio. Soltanto stretta nella morsa esatta del verso e della rima (e velata dal gioco delle maschere e dei nascondimenti dell’io), una materia proteiforme come quella amorosa potè divenire canto, sottrarsi al flusso dell’indicibile, aprirsi a un intendimento metafisico e religioso della parola poetica. Salutz – che il Saggiatore ripropone con un prezioso scritto di Giovanni Raboni – segna un punto di svolta non solo per il suo autore, ma per la letteratura italiana degli ultimi trent’anni. Percorsa da momenti di lirismo di ineguagliato splendore, da un senso della fragilità umana vissuta come colpa e solo a tratti riscattata dalla poesia, quest’opera dalla bellezza cupa e luminosa rivela fin dal titolo il suo valore di congedo. È il testamento sotto forma di poema amoroso in cui Giovanni Giudici, avvicinandosi all’ultima stagione della vita, giunse a chiedersi: «Se si troncasse il filo di futile bava / Che tiene appesa questa vita di ragno / Cosa sarete voi / Oggetti che sapevate il caldo della mia mano?».
Giovanni Giudici
Giovanni Giudici è nato a Le Grazie nel 1924 e morto a La Spezia nel 2011. Oltre che poeta è stato giornalista, saggista e traduttore. Tra le sue opere ricordiamo La vita in versi (1965), Autobiologia (1969), O Beatrice (1972), Il male dei creditori (1977), Il ristorante dei morti (1981), Lume dei tuoi misteri (1984), Prove del teatro (1989), Fortezza (1990), Quanto spera di campare Giovanni (1993), Empie stelle (1996), Eresia della sera (1999). Nel 2000 ha pubblicato, nei Meridiani Mondadori, I versi della vita, la raccolta completa della sua opera poetica a cura di Rodolfo Zucco. Ha tradotto, tra gli altri, Aleksandr Puškin, Sylvia Plath ed Ezra Pound.
scopri di più sull'autoreRassegna stampa
14 febbraio 2017
22 gennaio 2017
18 dicembre 2016
29 novembre 2016